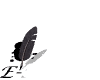TEMATICHE:
Due passi nell'Italia nascosta
Simbologia e Cultura Orientale
UTILITY:
Ricerca veloce titoli per argomento
SERVIZI:
|
Il simbolismo ermetico del Campanone di Gubbio |
||
| di Mario Farneti | ||
|
Disegno di Vincenzo Ambrogi
La superficie del Campanone è costellata di simboli ermetici che compongono un tessuto di non facile interpretazione. Come si sa, scopo di ogni buon ermetista è quello di nascondere, attraverso i simboli, la sintassi di un messaggio diretto ad altri, in grado come lui di decifrarli anche dopo millenni e senza necessariamente parlare la stessa lingua. Non c'è dubbio che Giovanbattista Donati, maestro fonditore, conoscesse molto bene la simbologia ermetica. Forse attraverso i simboli che ci ha lasciato si potrebbe svelare il segreto della fusione del Campanone e degli elementi (chimici e alchemici) grazie ai quali è costituito. Uno dei motivi ricorrenti sulla circonferenza del Campanone, al di là della simbologia prettamente cristiana (almeno in apparenza), è quello della Salamandra. Essa è, secondo la Tradizione, l'animale che vive nel fuoco e che il fuoco non può consumare. Rappresenta, per questa sua capacità, la pietra incandescente dei Filosofi che non si esaurisce mai. Certo un fonditore di campane non poteva scegliere animale più appropriato, anche perché, proprio per questa sua capacità di resistere al fuoco, la Salamandra resiste anche ai fulmini. Questo animale mitico, che compare sul Campanone per quattro volte in corrispondenza dei punti cardinali, è abbinato ad altri simboli: la Fenice, l'Aquila, la Rosa e la Farfalla. La Fenice ha anche essa attinenza col fuoco, perché, come si sa, ha il potere di rinascere dalle proprie ceneri. In alchimia essa è «uccello colorato con tutti i colori della Grande Opera» (Fulcanelli, Le Dimore Filosofali, Roma 1973), sui quali predomina il rosso porpora, in greco Phoinix. E’ il simbolo della rigenerazione e dell'eterno ritorno. Anche l'Aquila ha un significato importante; per questo riportiamo alcuni passi da Fulcanelli (ibidem): «Far volare l'aquila, secondo l'espressione ermetica, significa far brillare la luce togliendola dal suo scuro rivestimento e portandola alla superficie. Filalete afferma che la quinta aquila discioglie la luna, ma che se ne devono necessariamente usare da sette a nove per raggiungere lo splendore caratteristico del Sole. Le tre soluzioni successive danno vita al "Solve et Coagula", che aprirà la strada alla realizzazione della Pietra Filosofale. Angelus Silesius aggiunge: "L'aquila guarda senza timore il Sole bene in faccia e tu puoi guardare la luce eterna, se il tuo cuore è puro". Nei Salmi essa viene considerata simbolo di rigenerazione al pari della Fenice». Tra l'immagine di Sant'Ubaldo e del Crocifisso c'è, sempre abbinato alla Salamandra, il simbolo della Rosa che rappresenta le piaghe di Cristo e per questo si trova vicino alla croce. Essa evoca anche l'immagine del Santo Graal. La sua vicinanza col Crocifisso potrebbe servire a definire il rango, in campo ermetico, dell'artefice del Campanone. Gli stessi gigli che contornano il Crocifisso corrispondono araldicamente alla rosa ermetica. Sempre secondo Fulcanelli (ibid.): «Il fiore di giglio araldico corrisponde alla rosa ermetica. Unito alla croce, esso serve, proprio come la rosa, d'insegna e di blasone al cavaliere praticante che, per grazia di Dio, ha realizzato la pietra filosofale». Al pari della Fenice, la Farfalla è simbolo di trasformazione. Rappresenta l'anima che, uscita dal corpo, raggiunge un grado superiore di perfezione. In questo caso la crisalide rappresenta il corpo umano che contiene le potenzialità dell'essere e la farfalla che esce è un simbolo di resurrezione, di uscita dalla tomba: «Quella che il bruco chiama la fine del mondo, il maestro la chiama farfalla» (Richard Bach). Ritornando al Crocifisso, notiamo che la sua immagine grafica è costituita da una croce che sovrasta un triangolo (il monte Calvario). Secondo la Tradizione il triangolo col vertice rivolto verso l'alto rappresenta il fuoco. Cristo infatti è venuto a mettere il fuoco nelle cose: «Igne veni mittere in terram, et quid volo nisi accendatur?» (Io sono venuto a mettere il fuoco nella terra, e che voglio, se non che si accenda? - Luca, XII, 49). Un'altra notazione va fatta a proposito del triangolo: i due lati che formano i declivi del monte Calvario sono composti da dieci gradini. Si tratta della «Scala dei Saggi» che deve essere percorsa gradino per gradino e con pazienza dai discepoli della Scienza Sacra, per raggiungere la conoscenza, raffigurata dalla croce (sapienzale). L'Immacolata rappresenta la Madre, etimologicamente Mater da cui Materia. E anche la «matrice» degli alchimisti, come la luna. Essa poggia infatti sopra un crescente lunare ed è contornata da un'aureola di stelle a sei punte. La stella a sei punte rappresenta poi l'unione del cielo e della terra ed è composta da due triangoli sovrapposti, di cui uno rovesciato (Sigillo di Salomone) che simbolizzano unione, pacificazione e procreazione. Nel linguaggio ermetico, sempre secondo Fulcanelli, «stella» significa «fissazione del sole» e si può dedurre da questo inno cristiano: Latet sol in sidere, Il sole è nascosto sotto la stella Oriens in vespere, L'Oriente nel tramonto, Artifex in opere; L'artigiano è nascosto nell'opera; Per gratiam Con l'aiuto della sua grazia, Redditur et traditur È reso e riportato Ad patriam Alla sua patria La figura di San Giovanni Battista è abbastanza anomala, tanto da lasciar pensare che non si tratti di lui, anche se è citato nell'invocazione. Somiglia troppo a San Giacomo di Compostella, perché a differenza del Battista non porta la croce, ma un bastone con bisaccia da viandante e sulla mano sinistra stringe qualcosa di simile ad un pomo, forse la classica zucca. A definire in maniera certa la figura manca la conchiglia che potrebbe trovarsi sul copricapo, ma la testa del santo è consunta e quasi illeggibile. Il Sentiero di San Giacomo è la strada stellata, accessibile solo agli eletti, ai valorosi, ai sapienti e ai perseveranti. Il pellegrinaggio a Santiago è un'operazione obbligatoria per tutti quelli che vogliano intraprendere la strada dell'alchimia: «Sentiero aspro, gravoso, pieno di imprevisti e di pericoli. Strada lunga e faticosa è quella attraverso la quale il potenziale diventa attuale e l'occulto manifesto! I saggi, dunque, hanno velato, con l'allegoria del pellegrinaggio a Compostella, la delicata preparazione della materia prima, o mercurio comune» (Fulcanelli, ibid.). Che dire poi dell'immagine di Sant'Ubaldo? Donati non poteva ometterla, come forse ha fatto con San Giovanni Battista, ma non stona certo nel contesto della simbologia del Campanone. Lo conosciamo tutti come esorcista, taumaturgo, costruttore. Che altro aggiungere se non che il suo corpo incorrotto sta lì a testimoniarci di aver percorso fino in fondo il «sentiero di Santiago?». Gli otto simboli rappresentano infine l'ogdoade, che nella tradizione sapienzale simboleggia il giorno successivo a quello della Creazione e sta a significare l'avvento di Cristo e Cristo stesso. (Da: Mario Farneti - Vincenzo Ambrogi "L'antica Arte del Suonare il Campanone della Città di Gubbio" Edigraph & Images, Roma 1992). Si pubblica per gentile concessione dell'Autore; l'articolo originale si trova al link: http://www.farneti.it/campanone.htm
|
Sezioni correlate in questo sito:
www.duepassinelmistero.com Avvertenze/Disclaimer
Gennaio 2011