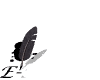TEMATICHE:
Due passi nell'Italia nascosta
Simbologia e Cultura Orientale
UTILITY:
Ricerca veloce titoli per argomento
SERVIZI:
|
IL SEGNO DEGLI SCALPELLINI A VÉZELAY |
||
| di Frans Ferzini © L'Informatore del Marmista-Giorgio Zusi Editore (consultabile presso la Biblioteca ISIC - Internazionale Marmi e Macchine di Massa-Carrara) | ||
|
In un piccolo villaggio borgognone una basilica testimonia il lavoro dei "costruttori di cattedrali".
Vézelay è un piccolo villaggio borgognone dalle stradine in salita che con severità e tenerezza conducono alla basilica di Sainte Marie-Madeleine, la cui mole domina il punto più alto, nell'attesa immobile e serena della "venuta dei cieli". Dal piazzale la basilica gioca coll'immutato orizzonte, aperto sul susseguirsi delle colline del Morvan e sul fondo della Valée de la Cure, da cui Girard de Rossillon stabilii nell' 860 circa, la comunità monacale che porterà alla fondazione della basilica di Vézelay. L'armonia basilicale con la natura circostante mi offre l'esempio sintonico tra realizzazione divina e costruzione dell'uomo, osmoticità che portano all'opera finita. Un negozio vicino, il Magasin du Pelerin, mi rammenta che il monastero è uno dei quattro punti di partenza delle strade per Compostela: la Via Lemocivensis. La storia non avrebbe conservato il ricordo di questo monastero se, all'inizio del XI secolo, non fosse sorto un culto straordinario a Maria Maddalena, attorno alle sue preziose reliquie conservate a Saint-Maximin - La Sainte-Baume e qui a Vézelay. Una moltitudine di pellegrini accorrono per venerare colei la quale "così tanto piacque a Dio, il suo amor puro..."; gli scultori si prodigarono a riempire di forme e segni della più grande tradizione, simbolica spesso occultata e offuscata dalla magnificenza del timpano del nartece e dalle storie narrate nel corteo di capitelli nelle navate. Le tracce più intime le scopro nel senso simbolico della porta nel nartece e nel luminoso deambulatorio ricco di segni lapidari e di luce. Superato il portale d'entrata, da quella facciata, la cui struttura originale del 1150, è stata variata con un'aggiunta di un frontone gotico nel 1250, si accede al nartece sulla cui parete ovest, un secondo portale è campeggiato da un maestoso timpano in cui la figura del Cristo, si muove nella sua forma ieratica e allargando le braccia afferma: "Io sono la porta!". Dalla penombra del nartece si apre un cammino luminoso, ritmato da colonne che conducono la pacatezza luminosa all'intensità sfavillante del coro. Ciò che può apparire separazione è in realtà di sorprendente continuità.
I costruttori conferirono alla pietra l'idea della continuità progressiva dal peso oscuro alla leggerezza totale della luce. Ecco il particolare senso di "passare" dalle tenebre dell'ovest alla luce del sole nascente, trionfo definitivo del Cristo sulla morte. Non a caso il nartece era definito nel XII secolo, "Galilea", proprio perchè il Cristo dicendo a Maria Maddalena "Io vi precederò in Galilea" precisa che la Galilea è il "Luogo del passaggio", la "Porta stretta" che conduce alla resurrezione. "Luogo di passaggio" era pure in aramaico, il luogo in cui Giovanni battezzava e nel quale designò Cristo come Agnello di Dio; chi varca la soglia del nartece della Maddalena è accolto da una chiarificazione dell'occhio e dell'anima. La contrapposizione al regno della morte è quello dell'est, là ove il coro diviene deambulatorio nel continuo spaziale che dal colonnato delle navate s'innesta, morbido ed armonico nelle graziose cappelle disposte a raggiera, in un inseme di universale geometria.
Navata della chiesa (foto: F. Ferzini) Ordine, misura e bellezza, sono le regole compositive da imitazione dell'opera di Dio, il costruttore medievale, affascinato dalla bellezza universale vuole edificare "l'anticamera del cielo", come Salomone costruisce secondo totale sottomissione alle norme fissate dal cosmo il quale "...narra la gloria di Dio e l'opera delle sue mani annunzia il firmamento" (Salmo 18,2).
E' qui, nel deambulatorio, che lo scalpellino ha impresso il suo marchio compagnonico, una misteriosa pentalfa, stella dal segreto del numero d'oro, marchi personali e soprattutto foglie lobate scolpite in pieno fusto colonnare, antico simbolo corporativo il cui segreto è addirittura radicato nei più profondi arcani d'origine celtica: la Confédération Eduenne dei Centonaris. Tutti segni comunque a definire il senso profondo dell'esser costruttori di cattedrali, percepibile tuttavia in ogni plastica romanico-gotica, nei costoloni, nelle modanature e nei rapporti di passaggio tra basamento, fusto e capitello e in ogni luogo ove il rapporto chiaroscurale sia evidente. Rapporto non solo atto a dichiarare il valore volumetrico dei corpi, ma soprattutto la simbologia tradizionale di "vita dell'uomo", l'ambivalenza di "materia lavorata" la pietra e l'anima umana.
Marche di scalpellini:
1) pentalfa
2) marca
fogliata
3) marca
semplice
4) marca trifogliata (
foto Frans Ferzini)
Non a caso, quegli scalpellini che hanno "firmato" le colonne del coro, sono ancora quelli di oggi che presso i Compagnons du Devoir de Liberté, hanno l'appellativo di Loup dal momento che il lupo è animale apollineo, figlio di tenebra e come luce esce dall'ombra divorandola, crea brani di luminosa speranza contrapposta agli oscuri pozzi della coscienza. (Autore:Frans Ferzini www.ferzinifrans.com ) |
Sezioni correlate in questo sito:
| Architetture | |
| Simbolismo |
www.duepassinelmistero.com Avvertenze/Disclaimer
Gennaio 2011